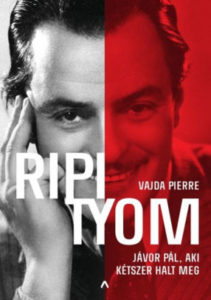Péter Nádas (o meglio Nádas Péter, come bisognerebbe scrivere secondo la regola che vale non solo per la lingua ungherese – ma anche per quella giapponese, per esempio – che vuole l’anteposizione del cognome al nome) nasce il 14 ottobre 1942 a Budapest, primogenito di una coppia di ebrei appartenenti alla piccola borghesia ungherese che lo fa battezzare con rito protestante. I genitori muoiono prematuramente e lui e il fratello minore di sei anni vengono affidati alle cure di parenti. Nádas interrompe gli studi superiori, che porterà a termine solo da adulto, impara l’arte della fotografia e trova impiego come fotografo presso una rivista. Nel 1962 inizia la sua relazione con la giornalista Magda Salamon, che sposerà nel 1990. Il suo primo volume, La Bibbia e altri racconti
[1], una raccolta di racconti, esce nel 1967, ma il vero riconoscimento arriverà con il romanzo, terminato nel 1972 e pubblicato solo cinque anni dopo, Fine di un romanzo familiare
[2]. Fra il 1974 e il 1979, lavora come redattore e revisore al periodico pedagogico “Gyermekünk” (Nostro figlio). Dal 1979, svolge la professione di giornalista e fotografo, e si dedica alla stesura del suo primo grande romanzo, Libro di memorie
[3], composto prevalentemente nei suoi ritiri in campagna, prima a Kisoroszi e poi nel piccolo villaggio, abitato da poche decine di anime, di Gombosszeg. Portato a termine Libro di memorie
nel 1985, comincia la stesura del suo secondo monumentale romanzo, Párhuzamos történetek
(“Storie parallele”). Trova però il tempo per occuparsi anche di opere più brevi e i suoi lavori vengono regolarmente tradotti in diverse lingue. La critica ungherese e quella internazionale, sempre più attente e interessate al suo lavoro, gli assegnano premi man mano più prestigiosi. Nel 1993 viene colpito da infarto, ma riesce a rimettersi e riprende la sua attività di scrittore. Nel 1995 viene insignito del Premio di Lipsia. In Francia nel 1998 Libro di memorie
è il miglior libro straniero dell’anno. Nel 1999 Rowohlt, storica casa editrice tedesca, pubblica tutte le sue opere in edizione tascabile. Contemporaneamente si afferma anche come fotografo, con diverse mostre in Europa. Nel 2005 esce, dopo diciotto anni di lavoro, Storie parallele
, in tre volumi. Ormai Péter Nádas è uno scrittore universalmente acclamato dalla critica e molto amato dal pubblico. Da anni il suo nome compare regolarmente fra i potenziali candidati al Nobel per la letteratura. Nel 2017 ha pubblicato in due volumi la sua ultima fatica, un meraviglioso romanzo autobiografico di 1212 pagine intitolato Világló részletek
(“Dettagli illuminanti”). In Italia, Péter Nádas ha avuto una storia editoriale avventurosa, in gran parte ancora da scrivere e in attesa di un meritato e, si auspica il meno tardivo possibile, rilancio.
![nadas_selfportrait (1)]()
Quest’anno, in un contesto di forte concorrenza, Világló részletek (“Dettagli illuminanti”), il memoir di Péter Nádas, è stato insignito del premio Aegon [nel 2017 l’ambito riconoscimento era invece andato a un altro autore monumentale della letteratura ungherese – che dopo l’assegnazione del Man Booker International Prize nel 2015 ha riscosso una rinnovata attenzione sia editoriale che di pubblico anche fuori dall’Ungheria –, László Krasznahorkai, per il romanzo (ancora inedito in Italia) Báró Wenckheim hazatér című (“Il ritorno a casa del barone Wenckheim”)].
Világló részletek dal canto suo è un’opera davvero imponente e anche il tavolo più solido appare intimorito sotto il peso delle sue quasi 1300 pagine.
Nádas mi riceve nella sua casa nel vecchio quartiere della Fortezza, nucleo originario di Buda
[4], in mezzo a oggetti che per lui hanno un significato speciale, alle sue opere e a scaffali colmi di libri. Una scrivania rivolta verso la luce che proviene da due finestre occupa il centro della stanza nella quale vengo accolta. È uno spazio tranquillo, arioso e ordinato che è un po’ come ci si immagina Nádas stesso. Prima di ogni cosa, mi mette in mano il secondo volume di
Világló részletek, perché ricorda che l’ultima volta che ci siamo incontrati mi aveva fatto dono, accompagnato dalla sua dedica, solo del primo libro.
Servono anni per scrivere un romanzo monumentale. Cos’è che spinge a farlo?
Nessuno desidera affrontare tanto lavoro, ma alla fine è l’opera che lo decide. Lo osserva anche Thomas Mann nei suoi diari: voleva scrivere una novella e nacque la Montagna magica, quello che sarebbe dovuto essere solo un racconto si trasformò nel Doctor Faustus. Certi materiali esigono molto spazio. Io c’entro, ma relativamente. E quei miei libri che lei vede così mastodontici sono stati sottoposti a energiche sforbiciate. Cerco di tagliare tutto il superfluo, e quello che vede è solo ciò che rimane.
All’inizio non sospetta nemmeno quanto lungo sarà il testo?
So dove sono diretto ma non ho idea dello spazio che ci vorrà. Viene fuori strada facendo, giorno dopo
![vilaglo-reszletek-nadas]()
giorno. In letteratura, nella
Bibbia, nella scrittura, sono interessanti i dettagli. La trama in quanto tale è una novità. Basta vedere
i romanzi americani di un tempo:
Moby Dick è un libro corposo, i romanzi di Theodore Dreiser sono in due volumi.
La brevità, il susseguirsi di dialoghi e descrizioni, è un’esigenza imposta agli autori da Hollywood. Una tendenza
nuova rispetto alla scrittura. Una parte dei lettori lo gradisce molto certo, ma non è una peculiarità della narrativa, bensì della
sceneggiatura.
Anche leggendo i migliori come Hemingway o Fitzgerald si ha la sensazione di vedere un film. Un’esigenza imposta agli editori a partire dagli anni Venti che a loro volta l’hanno trasferita agli scrittori ed è diventata una moda diffusa in tutto il mondo. Ma non tutti amano le semplificazioni, io per esempio decisamente no, e fra l’altro non tutti ne sono capaci.
Semplificare significa falsificare la ricchezza e la complessità che la vita rappresenta?
Non direi così, perché l’uomo vive un certo tipo di complessità e se la si ritrova in una novella, come accade in Cechov, va anche bene. Più raramente capita di trovarla anche in Hemingway.
La compattezza è poesia. La prosa è diversa, dispiega, esamina, approfondisce, guarda dietro. Osserva gli episodi, la loro concatenazione, i protagonisti, i grandi flussi narrativi e la loro interazione. Questo è il compito della prosa. Che può anche arrivare a condensare, ma mancherà sempre di qualcosa, e non rispecchierà la vita nella sua qualità di flusso epico. Mentre la narrazione, lo sforzo di raccontare sono state inventate proprio per questo.
Questa è un’affermazione ingannevole, perché quando raccontiamo una storia la revisioniamo: tagliamo gli elementi privi d’interesse, ne mettiamo in risalto altri; apportiamo delle modifiche.
Sì, e lo scrittore pur essendo dopo qualche decennio di attività un esperto, incontra ugualmente sorprese fino all’ultimo momento. Le accettiamo, ne prendiamo conoscenza, non le temiamo. Per esempio, nelle grandi favole dell’antichità come quelle di Esopo o delle Mille e una notte, ci sono notevoli divagazioni. E sono lì per tenere sveglia l’attenzione, cosa che può essere possibile soltanto se si evita la monotonia.
![nadas_peter_grafias]() Le divagazioni, i mondi interessanti che si spalancano uno dopo l’altro, servono a scacciare la noia del lettore?
Le divagazioni, i mondi interessanti che si spalancano uno dopo l’altro, servono a scacciare la noia del lettore?Al lettore servono soprattutto perché possa rendersi conto della ricchezza della vita. Sa che è così, ma non ha tempo di occuparsene finché deve mantenere i figli, deve lavorare, deve conseguire dei risultati. Quindi è compito dello scrittore trovare il tempo necessario.
E lei ce l’ha presente, ne è consapevole per tutto il tempo della scrittura? Affinché emergano questi ricchi dettagli della vita che il lettore possa sperimentare?
Assolutamente sì. Mi ci concentro su sedici ore. O meglio su centosedici.
Qual è il numero che più si avvicina alla realtà?
Diverse migliaia. Quando si scrive un testo così corposo come Világló részletek, il cervello umano diventa un computer. Redige contemporaneamente testo e immagini. Sa quando, dove e che cosa mettere, e che risposte deve ottenere dal punto di vista delle armonie. Sa dov’è diretto il ritmo e quali soluzioni troverà una volta arrivato. Significa gettare continuamente uno sguardo in avanti e uno all’indietro, tornare indietro nelle pagine e consultare le note.
Con Esterházy [Péter Esterházy (Budapest 1950-2016) tra i maggiori scrittori contemporanei ungheresi] ci divertivamo molto quando ci raccontavamo degli appunti geniali presi su pezzetti di carta gelosamente custoditi e poi mai più consultati. A lavoro finito, rispuntano fuori questi foglietti, li consultiamo e constatiamo sbigottiti che cosa di molto meglio avremmo potuto fare, capiamo cosa sarebbe potuto nascere. Mentre il libro è già stato stampato e pubblicato.
Non è un problema. Fa parte delle cose che si comprendono e accettano da vecchi: che quello che dimentico deve essere dimenticato. Merita di essere dimenticato. Sarà pure stato un buon episodio, ma ormai non si inseriva più nel sistema, e non se ne sente alcuna mancanza.
Con questo romanzo, il compito non era forse trovare proprio questi episodi? I piccoli episodi che gravitano intorno ai grandi ricordi importanti, quelli custoditi dalla radice del ricordo, che da soli non emergerebbero mai, perché secondari?
![nadaspeter4]()
©Péter Nádas
La memoria non funziona in questo modo. Lei parla di radici, io invece li chiamo cespugli, do un nome a quello che sta sopra, lei invece a quello che sta sotto.
Succede che per caso mi viene in mente un’idea, una frase, un’immagine, un odore – come Proust ricordava il sapore delle madeleine, un dolce semplicissimo –, che per l’effetto del cespuglio a sua volta mi fa tornare in mente tutto il resto. Da quel momento in poi è inarrestabile. Ci vengono in mente tanti ricordi di tante cose e la memoria corre in tante direzioni. Lo scrittore deve gestire la memoria, perché la letteratura non è la vita ma è la vita delle parole; e la vita del testo è una vita diversa. Tuttavia, il modello si trova nel pensiero, nella serie di associazioni di idee. Che funziona nello stesso modo per tutti. Nessuno ricorda in modo diverso.
Ha detto che il testo sarà tanto lungo quanto deve esserlo. Da dove arriva però la motivazione per comporlo? In quale parte del corpo ha origine la sensazione di doverlo scrivere?
Vi partecipano tutte le parti del corpo, compresi gli organi. Fra l’altro, limitatamente al tempo del lavoro, avvengono anche importanti trasformazioni.
Ad esempio, per trasformarsi in donna occorre una sensibilità, una percezione diversa. Nel senso biologico della parola. In quel caso avviene una vera e propria trasformazione. Non sto scherzando.
Forse soltanto mia moglie potrebbe raccontarlo, ma anche lei può notare solo i segnali esterni.
![parallel_stories_peter_nadas]()
Naturalmente capita di rado. Quando lavoravo a
Párhuzamos történetek (“Storie parallele”), mi trasformavo in donna per settimane,
assumevo una percezione femminile su molte cose. Contribuivano le ricerche, le letture, gli interrogatori che facevo a amiche e conoscenti femminili su determinati argomenti. Interrogatori dettagliati ai quali non erano mai state sottoposte prima, ai quali si sottraevano o rispondevano volentieri. Dopodiché ero io a dovermi immedesimare, dal parto alla penetrazione. E fino a un certo punto non era impossibile. Tuttavia erano insiti anche grandi errori. Per fortuna avevo delle lettrici che mi avvertivano se con la fantasia prendevo una direzione sbagliata e quindi immancabilmente maschile.
Una volta Éva Ruttkai [celebre attrice ungherese del secolo scorso (Budapest 1927-1986)] mi dimostrò in quante parti del corpo è possibile generare una voce. Cominciò sopra la testa e poi continuò per tutto il corpo. Ovunque scaturiva una voce: dalla pianta del piede, dal centro della gamba, voci diverse da quelle emanate dal petto o dalla gola. Un attore dovrebbe sapere generare una voce con ogni parte del corpo. Fa parte del suo mestiere.
È possibile individuare l’origine del desiderio che porta a dedicarsi alla scrittura per così tanto tempo?
Non lo so. Io ho cominciato a scrivere a undici anni e non ho mai più smesso. Ecco. Punto.
![Na_das5]()
Péter Nádas @Csiszér Goti/WMN – Goti Photography
Scrive tutti i giorni?
Tutti i giorni. Anche oggi, prima del vostro arrivo, ho buttato giù degli appunti.
Tiene un diario?
No. No, non ne ho mai tenuto uno.
Sarebbe stato uno spreco di tempo?
![nadas_peter_photo]()
Péter Nádas ritratto in una foto di famiglia. ©Péter Nádas
Leggo volentieri diari, è un genere letterario molto interessante. Non mi sono però mai sentito importante al punto da prendere annotazioni su di me. Nelle annotazioni c’è sempre qualcosa che parla agli altri. Ci sono diari molto egoisti. Thomas Mann ha lasciato dieci volumi in cui racconta di tutto, anche delle questioni più intime e più astratte. Aveva una consapevolezza di sé che io non ho. Io so scrivere solo mascherato, da attore. Mi serve una sorta di trasposizione.
Ho l’impressione che l’intera esistenza di uno scrittore sia spesa al servizio di qualcosa. Anche se è un lusso poterselo permettere, altrimenti forse non avrebbe continuato a farlo dall’età di undici anni.
Una vita di lusso in quanto faccio solo quello di cui sento la necessità, il bisogno, e l’ho fatto per tutta la vita.
Anch’io intendevo questo.
Questo è il lato lussuoso. Per il resto è schiavitù.
Appunto, dicevo che è un servizio.
La religione si è appropriata del termine servizio, si tratta comunque di una sorta di consapevolezza del proprio dovere. Che è imprescindibile. Ogni giorno lavorativo ha una fase introduttiva, in cui si raggiunge una certa altura, oppure non si arriva da nessuna parte. Oppure si arriva almeno a correggere quello che si è scritto il giorno prima. Lavoro, gioia, ineluttabilità, tante cose assieme. Non ci sono giorni di festa né si parte per andare in vacanza. La sera devo fare attenzione all’alcol per non compromettere l’indomani mattina. Bisogna sapere quando è il caso di interrompere e quando invece bisogna proseguire. Quali legami si possono stringere e quali no, in base allo stato del lavoro. Si conduce una vita monacale. Si rimane fuori da molte cose che per gli altri sono del tutto normali.
Quando è stato pubblicato il Libro di memorie mi sono divertito molto perché qualcuno mi ha dato dell’erotomane. Può darsi, dicevo, stando seduti interi anni alla scrivania. Anche il marchese de Sade sedeva alla Bastiglia e scriveva quell’opera pregna di terrificante fantasia che aveva molto a che fare con la realtà, ma non certo con la sua.
![nadas69b]()
©Péter Nádas
Questa vita è fatta anche di rinuncia attiva: ne è sempre consapevole?
Rinuncia, sì. Automutilazione nell’interesse di qualcosa. Con i lavori molto estesi la cosa più difficile è mantenere lo stesso livello. C’è il ricambio delle cellule umane ogni sette anni, quindi le persone cambiano. Anche se non esistono trasformazioni radicali e si rimane quello che si era a quattro anni, continuiamo a cambiare, e le nostre vite sono suddivise in fasi. Io questo non posso permetterlo.
Allora è stato deciso: lei vivrà in eterno.
No, no, anzi, consumiamo abnormi quantità di energie. Gli scrittori di prosa di solito non vivono a lungo.
Diamo un’occhiata alle unità minori, alle parole; per esempio da dove viene la parola briftasni?
Dalla lingua di Budapest, dove nella metà dell’Ottocento si parlava ancora il tedesco, o almeno due se non cinque, ma in realtà un numero indefinito, di lingue. Quando si iniziava a costruire, alla fine dell’Ottocento, la città diventava plurilingue perché arrivavano i ruteni, gli slovacchi e portavano le loro lingue che contribuivano a questa mescola. In particolare i termini tecnici che usiamo ancora oggi – o almeno fino a ieri, perché la mia visione non arriva all’oggi –, insomma che usavamo fino a ieri erano prevalentemente di origine tedesca. Anche se li consideriamo come se fossero ungheresi oppure magiarizzati.
Possiamo trovare un paragone che rispecchi il progredire di questo libro? Abbiamo parlato di cespuglio o radici dei ricordi, ma c’è questa continua apertura a nuove strade e questo incessante ritorno indietro, quindi la comparazione con il cespuglio regge solo fino a un certo punto, l’accostamento sarebbe calzante solo se scoprissimo che sottoterra tutte le radici si congiungono. Cosa si può dire di quest’esperienza narrativa, delle sue congiunzioni, che sono come…? Ce lo dica lei.
Strutture differenti in movimento che si congiungono. Se una voluminosa opera in prosa non dispone di una struttura interna tale da permettere al lettore di procedere con cognizione di causa, finisce con il ridursi in polvere. Vale anche per l’autore, neppure lui riesce ad andare avanti. Queste strutture devono essere più pesanti, più importanti del materiale che portano.
Uno scrittore deve sapere di struttura più di quanto appaia. Si dice, anche se la formulazione non è abbastanza precisa, che emerge solo la punta dell’iceberg, il resto nuota in profondità.
![peter_nadas_cover]()
Sì, neppure questa formulazione è precisa, perché qui si tratta di connessioni, di legami incrociati.
Di ordini. Ci sono molti tipi di ordini. Uno riguarda le scelte lessicali, un altro tutto quello che ho tralasciato, che non ho incluso nel testo. I lettori di Világló részletek reclamano molte assenze. Cose che non ho inserito nel testo (ride). Così, su due piedi, non saprei dire quali, ma è il risultato di riflessioni.
Con Miklós Mészöly [(Budapest 1921-2010) scrittore, drammaturgo e saggista] e Péter Esterházy era possibile discutere molto bene di questioni professionali, e con Esterházy ci siamo detti molte volte che un testo non porta in sé soltanto quello che c’è scritto, ma anche tutto quello che è stato lasciato fuori.
Dunque quello che manca è stato omesso di proposito.
Sì, e come nella musica, le omissioni hanno un certo ritmo, seguono un certo ordine. Così come le frasi hanno un ordine, ce l’hanno anche le frasi monche. Grácia Kerényi, studiosa di filologia classica, dopo un po’ di tempo ha notato che io non usavo gli articoli. “Peti” (ero molto giovane all’epoca) diceva indignata, “Peti, non si possono non mettere gli articoli!”. “Grácia, anche gli articoli possono essere omessi. Se serve, si può fare a meno anche dell’articolo”.
Anche nelle nostre relazioni sappiamo di che cosa non dobbiamo parlare. Ma quei temi sono presenti nel suo libro, eccome.
Anche l’assenza produce un ordine. Pure la questione di cui non posso parlare perché non deve essere toccata. Ci sono testi completamente privi anche del più lontano accenno all’aspetto fisico delle persone. Non sappiamo come sono fatte, tuttavia ce ne facciamo un’idea partendo dalla loro voce, dal tono.
![nadas47b]()
©Péter Nádas
István Eörsi [(Budapest 1931-2005) scrittore, traduttore, poeta ma anche politologo ungherese] ha notato una volta qualcosa che mi sfuggiva: descrivevo con cura maniacale degli oggetti piuttosto insulsi rispetto al punto di vista della vicenda, di un personaggio o di una trama. Per me invece non lo sono per niente.
Mobili, stanze, atmosfere, viste, panorami da finestre, immagini della natura. Esterházy osservava invece che mi occupavo sempre della natura, mentre lui gridava ai quattro venti che la odiava. Chi legge le sue opere se ne rende conto: non trattava mai la natura, al massimo prendeva in prestito da me le descrizioni naturali. E lo faceva con grande piacere. Ma lui non se ne occupava.
La natura è ben reale, lo scrittore invece si intrattiene per lo più nella propria testa dove crea un mondo, seduto davanti al computer e…
Io non scrivo al computer.
Allora come?
Scrivo a mano. Io devo vedere i miei personaggi. Devo vedere quello che fanno e devo vedere il paesaggio in cui si inseriscono, la stanza, i colori. Lo schermo, le font, mi disturbano.
La calligrafia invece no?
Scrivo automaticamente. Su un pezzo di carta in grembo, mentre guardo fuori dalla finestra.
Per lavoro crea mondi spirituali e anche noi sostiamo nel nostro mondo immaginario quando leggiamo. Mentre, come forma di riposo, non si dedica a qualcosa di fisico, di reale? Che ne so, come piantare dei fiori, fare la pasta, lavorare l’argilla?
Invidio terribilmente gli artisti che creano con le mani. Hanno un rapporto completamente diverso con tutto. Tuttavia anch’io lavoro con la materia. Devo capire com’è fatta.
Da giovane, provavo davanti allo specchio le espressioni facciali, i gesti che mi premevano in quel momento. Esattamente come gli studenti di pittura alle lezioni di anatomia che vogliono vedere cosa genera cosa, che cosa muove i muscoli. Ho dovuto impararlo. Ora non lo faccio più, ma in passato dovevo sperimentare casi estremi per verificare. Provare dei ruoli. Spero che non mi abbia visto nessuno dalla finestra.
Invece è accaduto?
C’era stato un tempo in cui prendevo in affitto a Kisoroszi una camera, la cosiddetta camera pulita di una casa contadina, ed è capitato che la signora Zsuzsi, la vecchia che me la affittava, faceva vedere a qualche privilegiato cosa stessi facendo. In paese non capivano come trascorressi intere giornate. Una volta mi confessò di avermi spiato insieme ad altri.
È divertente immaginare persone in punta di piedi sotto la finestra nel tentativo di sbirciare dentro.
Vedevano soltanto me al tavolo seduto a fare nulla. Al massimo scrivevo, oppure stavo in piedi a un banco e battevo a macchina. Era tutto qui. Per loro non era lavorare.
In effetti.
E soprattutto non lavoravo nessuna materia. Un tempo a Kisoroszi aveva lavorato anche uno scultore, Miklós Melocco, che martellava la pietra calcarea. Quello sì che era lavoro ben identificabile.
I romanzieri raccontano spesso che una volta centrato un personaggio, lo osservano a distanza di qualche passo, affinché il personaggio stesso possa descriversi e scrivere la propria trama, seguendo una propria verità.
Sì, quando capita un personaggio del genere va solo assecondato.
Ma se lavora con i ricordi personali, come può essere colto di sorpresa?
La sorpresa è sempre necessaria. Un giorno senza è una gran brutta giornata. È molto interessante, perché mi avvio da varie direzioni verso qualcosa e queste vie, queste direzioni si incrociano. Tuttavia non sono io a decidere gli incroci, ma solo le direzioni. L’incrociarsi di due vie sembra un fenomeno naturale. In realtà gli incroci cui assisto sono sorprendenti. Se però nel testo questa serie di sorprese non assume una qualche forma di ordine, il testo si mette a zoppicare o a oscillare.
Világló részletek è un intreccio di ricordi. Se riguardassimo a questa mattina, pensa che la ricorderemmo in modo diverso, lei e io?
Certamente. Ne sono sicuro. Abbiamo vettori diversi, per così dire. Portiamo cose diverse da fonti diverse. L’unica cosa che abbiamo davvero in comune è la lingua. Com’era la parola che chiedeva?
Briftasni.
Briftasni. A me per esempio non verrebbe mai in mente di interrogarmi sulla sua origine perché la nostra è una lingua fatta a strati, che è semplicemente la lingua di Budapest, ma so in quali quartieri usano la parola briftasni al posto di “portafogli”. Nel settimo, nell’ottavo e nel sesto. Non negli altri. Un termine usato soprattutto in provincia. Gli artigiani e i commercianti tiravano fuori il briftasni. Le classi sociali più elevate non lo tiravano fuori, perché pagavano qualcun altro affinché lo facesse per loro, oppure lo prendevano senza dire nulla, in nessun caso pronunciavano la parola briftasni, al limite parlavano di portafoglio o portamonete.
Questa parola evoca mio nonno nato a Tereske, nella regione Fejér, e vissuto nel sesto distretto di Budapest. Esattamente come l’ha descritto.
Bene. Un ricordo maschile. Le donne non avevano briftasni, ma soltanto portafogli.
Si ricorda quando anni fa registrammo un’intervista a New York? Mi incuriosisce sapere che cosa si ricorda di quell’occasione, per capire se abbiamo ricordi molto diversi fra noi.
Ricordo parecchio. I ricordi sono diversi perché ognuno di noi ha un diverso punto di vista. Mi racconti lei i suoi e io li commenterò.
Ricordo il suo albergo, la stanza dove facemmo le riprese sembrava un salone, il rivestimento color oro spento della poltrona, lei poggiato allo schienale.
Per esempio io l’albergo non me lo ricordo.
Il ricordo più vivido è il suo pullover di lana. Da allora, quando penso a lei, la vedo sempre con quel pullover addosso. Ricordo anche che ne parlammo, che il collo a V del pullover di lana è un codice. Noi vediamo un raffinato capo d’abbigliamento, borghese e ben tenuto, ma poiché avevo letto le sue opere sapevo della sorprendente densità di significato presente sotto la piacevole superficie. Per nascondere la quale lei non ricorre all’inganno, ma la rende per così dire indossabile, celando così al mondo il tumulto interiore. Mi viene in mente sempre questa sua immagine. Una vita ricca, sensibile, di buona qualità, in versione tessile.
Capisco cosa intende. Da quando ne ho memoria mi sono sempre vestito in questo modo, quindi per me è naturale. Anche oggi. Mi metto la giacca solo per le grandi occasioni.
![Na_das9]()
Nóra Winkler e Péter Nádas @Csiszér Goti/WMN – Goti Photography
Concludo con una domanda cerimoniosa, ma va bene anche una sua risposta in pullover. L’umanità, la sua incredibile capacità di accettare, che potrei definire come una vera e propria forma di affetto, che è presente in tutti i suoi libri, ovviamente non è il risultato del lavoro, deve esserle congenita. Come fa a guardarsi intorno con tanta comprensione ed empatia?
Non posso parlarne senza mettere me stesso al centro della questione, anche perché io non la sento in questo modo e non lo dico apposta. Secondo me si tratta di dovere professionale. Senza il quale la faccenda non funziona. Sento decisamente alienante la letteratura in cui lo scrittore si erge sopra i protagonisti, in pratica li disprezza in quanto stupidi, cretini, incapaci. Perché significa che non si è avvicinato abbastanza a loro, oppure che non è stato all’altezza della situazione. E per questo non è riuscito ad avvicinarli. La prossimità mi piace molto, il che comporta tutta una serie di cose, anche non permesse. Una sorta di sapere poi chiamato conoscenza a posteriori, del retroscena. Che per me è invece a priori.
[1] Péter Nádas,
La Bibbia e altri racconti, traduzione di Andrea Rényi, BUR, Milano 2009.
[2] Péter Nádas,
Fine di un romanzo familiare, traduzione di Laura Sgarioto, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2009.
[3] Péter Nádas,
Libro di memorie, traduzione di Laura Sgarioto, Alexandra Foresto, Vera Gheno e Krisztina Sándor, Dalai, Milano 2012.
[4] Budapest nasce nel 1873 dalla fusione di tre città, Buda, Óbuda e Pest, ciascuna delle quali aveva il suo centro storico. La Fortezza era quello di Buda.
![Diario di un esule per “scelta”. “Volevo tacere” di Sándor Márai Diario di un esule per “scelta”. “Volevo tacere” di Sándor Márai]() «Negli ultimi tempi i morti scrivono molto e tutte cose buone» disse Márai una volta a proposito delle pubblicazioni postume dei grandi scrittori ungheresi che lo avevano preceduto: Dezső Kosztolányi e Gyula Krúdy. Potremmo dire altrettanto di lui, perché da anni escono, uno dopo l'altro, i suoi bei libri in Italia, e prima ancora in Ungheria, dove dal 1948 in poi, data della sua emigrazione, vietò sia l'esecuzione teatrale sia la pubblicazione delle sue opere.
«Negli ultimi tempi i morti scrivono molto e tutte cose buone» disse Márai una volta a proposito delle pubblicazioni postume dei grandi scrittori ungheresi che lo avevano preceduto: Dezső Kosztolányi e Gyula Krúdy. Potremmo dire altrettanto di lui, perché da anni escono, uno dopo l'altro, i suoi bei libri in Italia, e prima ancora in Ungheria, dove dal 1948 in poi, data della sua emigrazione, vietò sia l'esecuzione teatrale sia la pubblicazione delle sue opere.![Diario di un esule per “scelta”. “Volevo tacere” di Sándor Márai Diario di un esule per “scelta”. “Volevo tacere” di Sándor Márai]()
![Diario di un esule per “scelta”. “Volevo tacere” di Sándor Márai Diario di un esule per “scelta”. “Volevo tacere” di Sándor Márai]()
![Diario di un esule per “scelta”. “Volevo tacere” di Sándor Márai Diario di un esule per “scelta”. “Volevo tacere” di Sándor Márai]()
 «Negli ultimi tempi i morti scrivono molto e tutte cose buone» disse Márai una volta a proposito delle pubblicazioni postume dei grandi scrittori ungheresi che lo avevano preceduto: Dezső Kosztolányi e Gyula Krúdy. Potremmo dire altrettanto di lui, perché da anni escono, uno dopo l'altro, i suoi bei libri in Italia, e prima ancora in Ungheria, dove dal 1948 in poi, data della sua emigrazione, vietò sia l'esecuzione teatrale sia la pubblicazione delle sue opere.
«Negli ultimi tempi i morti scrivono molto e tutte cose buone» disse Márai una volta a proposito delle pubblicazioni postume dei grandi scrittori ungheresi che lo avevano preceduto: Dezső Kosztolányi e Gyula Krúdy. Potremmo dire altrettanto di lui, perché da anni escono, uno dopo l'altro, i suoi bei libri in Italia, e prima ancora in Ungheria, dove dal 1948 in poi, data della sua emigrazione, vietò sia l'esecuzione teatrale sia la pubblicazione delle sue opere.





 giorno. In letteratura, nella Bibbia, nella scrittura, sono interessanti i dettagli. La trama in quanto tale è una novità. Basta vedere i romanzi americani di un tempo: Moby Dick è un libro corposo, i romanzi di Theodore Dreiser sono in due volumi. La brevità, il susseguirsi di dialoghi e descrizioni, è un’esigenza imposta agli autori da Hollywood. Una tendenza nuova rispetto alla scrittura. Una parte dei lettori lo gradisce molto certo, ma non è una peculiarità della narrativa, bensì della sceneggiatura.
giorno. In letteratura, nella Bibbia, nella scrittura, sono interessanti i dettagli. La trama in quanto tale è una novità. Basta vedere i romanzi americani di un tempo: Moby Dick è un libro corposo, i romanzi di Theodore Dreiser sono in due volumi. La brevità, il susseguirsi di dialoghi e descrizioni, è un’esigenza imposta agli autori da Hollywood. Una tendenza nuova rispetto alla scrittura. Una parte dei lettori lo gradisce molto certo, ma non è una peculiarità della narrativa, bensì della sceneggiatura. Le divagazioni, i mondi interessanti che si spalancano uno dopo l’altro, servono a scacciare la noia del lettore?
Le divagazioni, i mondi interessanti che si spalancano uno dopo l’altro, servono a scacciare la noia del lettore?
 Naturalmente capita di rado. Quando lavoravo a Párhuzamos történetek (“Storie parallele”), mi trasformavo in donna per settimane, assumevo una percezione femminile su molte cose. Contribuivano le ricerche, le letture, gli interrogatori che facevo a amiche e conoscenti femminili su determinati argomenti. Interrogatori dettagliati ai quali non erano mai state sottoposte prima, ai quali si sottraevano o rispondevano volentieri. Dopodiché ero io a dovermi immedesimare, dal parto alla penetrazione. E fino a un certo punto non era impossibile. Tuttavia erano insiti anche grandi errori. Per fortuna avevo delle lettrici che mi avvertivano se con la fantasia prendevo una direzione sbagliata e quindi immancabilmente maschile.
Naturalmente capita di rado. Quando lavoravo a Párhuzamos történetek (“Storie parallele”), mi trasformavo in donna per settimane, assumevo una percezione femminile su molte cose. Contribuivano le ricerche, le letture, gli interrogatori che facevo a amiche e conoscenti femminili su determinati argomenti. Interrogatori dettagliati ai quali non erano mai state sottoposte prima, ai quali si sottraevano o rispondevano volentieri. Dopodiché ero io a dovermi immedesimare, dal parto alla penetrazione. E fino a un certo punto non era impossibile. Tuttavia erano insiti anche grandi errori. Per fortuna avevo delle lettrici che mi avvertivano se con la fantasia prendevo una direzione sbagliata e quindi immancabilmente maschile.






 Traduttrice dal tedesco di venticinque titoli e innumerevoli estratti per Keller, Voland, Viceversa Letteratura, BCD, Meridiano Zero, Ponte alle Grazie e Casagrande, insignita del Premio italo-tedesco per la traduzione letteraria, Roberta Gado è un’autentica mediatrice linguistica e culturale. Collabora con le principali fondazioni svizzere e il Babel Festival, co-dirige il Centro per la traduzione della prestigiosa Fiera del Libro di Lipsia, città in cui vive da alcuni anni con la famiglia, senza perdere di vista la letteratura italiana che patrocina presentando autori italiani in Germania in italiano e in tedesco. Laureata in Filosofia, Roberta Gado ha imparato il mestiere di traduttrice da autodidatta, diventando anche docente di corsi universitari di traduzione dal tedesco.
Traduttrice dal tedesco di venticinque titoli e innumerevoli estratti per Keller, Voland, Viceversa Letteratura, BCD, Meridiano Zero, Ponte alle Grazie e Casagrande, insignita del Premio italo-tedesco per la traduzione letteraria, Roberta Gado è un’autentica mediatrice linguistica e culturale. Collabora con le principali fondazioni svizzere e il Babel Festival, co-dirige il Centro per la traduzione della prestigiosa Fiera del Libro di Lipsia, città in cui vive da alcuni anni con la famiglia, senza perdere di vista la letteratura italiana che patrocina presentando autori italiani in Germania in italiano e in tedesco. Laureata in Filosofia, Roberta Gado ha imparato il mestiere di traduttrice da autodidatta, diventando anche docente di corsi universitari di traduzione dal tedesco.










 Il vocabolario Treccani definisce fanatico «chi è mosso da passione forte ed esclusiva, da entusiasmo per un'idea, per un partito, o anche semplicemente da simpatia eccessiva verso una determinata persona o da eccessivo zelo nell'esercizio di un'attività”, o “di ciò che rivela fanatismo». A Roma «la parola è usata con senso più generico, attribuita a chiunque nelle sue manifestazioni o nelle sue mansioni si mostri eccessivamente zelante, smanioso, o dia comunque prova di esagerazione in tutto ciò che fa, e anche persona boriosa, che ama mettersi in mostra.» Nel suo nuovo romanzo Cuori fanatici (Rizzoli) Edoardo Albinati, scrittore e sceneggiatore romano e Premio Strega 2016 con La scuola cattolica, presenta in dodici capitoli alcuni archetipi che ben illustrano il lemma. Sono un capannello di personaggi che ruotano intorno a due giovani amici, Nanni e Nico, in un'epoca molto vicina eppure molto lontana, che sono gli anni Ottanta. Prima però Albinati fa dono al lettore di un prologo dedicato alla città meridionale, sottofondo in gran parte dei ritratti e camei più o meno grandi che compongono questo libro, e dall'identità assai facile da scoprire.
Il vocabolario Treccani definisce fanatico «chi è mosso da passione forte ed esclusiva, da entusiasmo per un'idea, per un partito, o anche semplicemente da simpatia eccessiva verso una determinata persona o da eccessivo zelo nell'esercizio di un'attività”, o “di ciò che rivela fanatismo». A Roma «la parola è usata con senso più generico, attribuita a chiunque nelle sue manifestazioni o nelle sue mansioni si mostri eccessivamente zelante, smanioso, o dia comunque prova di esagerazione in tutto ciò che fa, e anche persona boriosa, che ama mettersi in mostra.» Nel suo nuovo romanzo Cuori fanatici (Rizzoli) Edoardo Albinati, scrittore e sceneggiatore romano e Premio Strega 2016 con La scuola cattolica, presenta in dodici capitoli alcuni archetipi che ben illustrano il lemma. Sono un capannello di personaggi che ruotano intorno a due giovani amici, Nanni e Nico, in un'epoca molto vicina eppure molto lontana, che sono gli anni Ottanta. Prima però Albinati fa dono al lettore di un prologo dedicato alla città meridionale, sottofondo in gran parte dei ritratti e camei più o meno grandi che compongono questo libro, e dall'identità assai facile da scoprire.

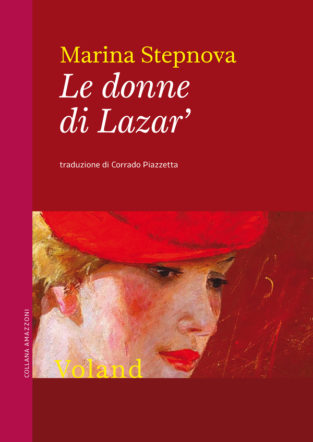






 Quando leggo qualcosa di veramente buono provo a immaginare cosa ne sarà fra cinquant’anni. Non lo saprò mai perché fra cinquant'anni io non ci sarò, ma molti dei lettori di Kehlmann sì, e con loro voglio fare una scommessa. Scommetto che Kehlmann sarà un autore letto e apprezzato anche nella seconda metà del nostro secolo, e soprattutto per questo libro. Credo che La misura del mondo, e forse qualcos'altro che Kehlmann scriverà dopoTyll (Feltrinelli), accompagneranno più generazioni, ma Tyll sarà anche studiato per l'ingegnosa commistione fra storia e fantasia, e sarà considerato come un caso di scuola della letteratura. Naturalmente contribuisce l'arte della scrittura di cui l'autore austro-tedesco è innegabilmente un grande maestro, ma il motivo principale è che in questo libro Kehlmann ha forzato il romanzo storico come nessun altro prima, creando una commistione molto impegnativa, eppure ben riuscita, in cui le difficoltà non scoraggiano, ma esercitano uno stimolo vitale. Mette il lettore continuamente alla prova e lo costringe a pesare pagina dopo pagina la percentuale di fiction da separare dalla storia vera e propria. Cosa che accade in tutti i romanzi che incorporano una fetta più o meno grande della Storia, dove però il lettore di solito sa che la cornice storica, ovvero la base su cui poggia il romanzo, è autentica. In Tyll questa distinzione è ardua, per non doversi impegnare troppo il lettore può optare per l'interpretazione interamente da fiction, ovvero per il tutto frutto dell'invenzione, ma vedendo comparire comunque persone realmente esistite e avvenimenti storici riportati nei libri di storia non può mai abbandonarsi al piacevolissimo flusso delle parole. Di conseguenza vive il romanzo non da percettore passivo, da lettore che si accomoda, ma con un continuo impegno mentale e anche sentimentale che interiorizza e consolida la lettura, rendendola indimenticabile.
Quando leggo qualcosa di veramente buono provo a immaginare cosa ne sarà fra cinquant’anni. Non lo saprò mai perché fra cinquant'anni io non ci sarò, ma molti dei lettori di Kehlmann sì, e con loro voglio fare una scommessa. Scommetto che Kehlmann sarà un autore letto e apprezzato anche nella seconda metà del nostro secolo, e soprattutto per questo libro. Credo che La misura del mondo, e forse qualcos'altro che Kehlmann scriverà dopoTyll (Feltrinelli), accompagneranno più generazioni, ma Tyll sarà anche studiato per l'ingegnosa commistione fra storia e fantasia, e sarà considerato come un caso di scuola della letteratura. Naturalmente contribuisce l'arte della scrittura di cui l'autore austro-tedesco è innegabilmente un grande maestro, ma il motivo principale è che in questo libro Kehlmann ha forzato il romanzo storico come nessun altro prima, creando una commistione molto impegnativa, eppure ben riuscita, in cui le difficoltà non scoraggiano, ma esercitano uno stimolo vitale. Mette il lettore continuamente alla prova e lo costringe a pesare pagina dopo pagina la percentuale di fiction da separare dalla storia vera e propria. Cosa che accade in tutti i romanzi che incorporano una fetta più o meno grande della Storia, dove però il lettore di solito sa che la cornice storica, ovvero la base su cui poggia il romanzo, è autentica. In Tyll questa distinzione è ardua, per non doversi impegnare troppo il lettore può optare per l'interpretazione interamente da fiction, ovvero per il tutto frutto dell'invenzione, ma vedendo comparire comunque persone realmente esistite e avvenimenti storici riportati nei libri di storia non può mai abbandonarsi al piacevolissimo flusso delle parole. Di conseguenza vive il romanzo non da percettore passivo, da lettore che si accomoda, ma con un continuo impegno mentale e anche sentimentale che interiorizza e consolida la lettura, rendendola indimenticabile.



 «Sono un devoto, di più, un fanatico della memoria degli sconfitti e rivendico con tutte le mie forze la dignità della disfatta» è il filo conduttore lungo il quale si dipana la narrazione storica e culturale d'Israele a cavallo fra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta, vista con gli occhi di un giovane ebreo polacco che in Israele da adolescente diventa adulto.
«Sono un devoto, di più, un fanatico della memoria degli sconfitti e rivendico con tutte le mie forze la dignità della disfatta» è il filo conduttore lungo il quale si dipana la narrazione storica e culturale d'Israele a cavallo fra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta, vista con gli occhi di un giovane ebreo polacco che in Israele da adolescente diventa adulto.